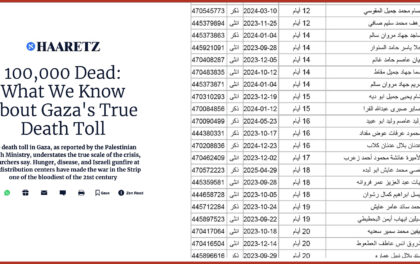Proust, le cattedrali e la bellezza della liturgia
 Tempo di lettura: 7 minuti
Tempo di lettura: 7 minutiMarcel Proust
Che Marcel Proust ritenesse le chiese gotiche le più nobili «opere alle quali si sia mai innalzato il genio di Francia» è risaputo: in À la recherche du temps perdu i nomi di Chartres, Amiens, Tours, Sens, Bourges, Auxerre, Clermont e Troyes ricorrono continuamente. E del resto la stessa Recherche era stata concepita, «costruita» e «ornata» perché rappresentasse una «cattedrale» nella storia della letteratura, ossia restasse in piedi «nel Tempo». Meno nota, invece, la sorprendente perorazione dello scrittore – non credente, ebreo per nascita e figlio di quel mondo che il poeta Charles Péguy, negli stessi anni, aveva definito prospero «senza Gesù, dopo Gesù» – in difesa dei secolari giganti di pietra d’Oltralpe, i quali nel 1904 rischiavano la sconsacrazione a causa della legge che sanciva la separazione tra Chiesa e Stato francese.
L’articolo di Proust apparve nell’agosto di quell’anno su Le Figaro, con un titolo forte – «La morte delle cattedrali» –, mentre l’intero Paese era intento a discutere alcuni punti di una legge che, tra le varie cose, prevedeva l’abolizione dei luoghi di culto, l’inventario di tutte le proprietà della Chiesa francese e l’istituzione delle associazioni cultuali, pena la confisca di quegli stessi beni da parte dello Stato. Il rischio che quest’ultimo s’impadronisse della gestione dei luoghi di culto cristiani per trasformarli in «semplici pezzi da museo, gelidi» sembrava imminente, e Proust temeva che di lì a qualche anno la Francia sarebbe divenuta «una spiaggia dove gigantesche conchiglie cesellate sarebbero apparse arenate, vuote ormai della vita che in esse aveva abitato ed incapaci di recare all’orecchio che si chinasse su di esse il vago rumore di un tempo». Questo perché, scriveva l’autore: «Quando il sacrificio della carne e del sangue del Cristo non sarà più celebrato nelle chiese in esse non ci sarà più vita».
Tale affermazione costituisce il primo grande punto nevralgico dello scritto proustiano. Sottolineando che la bellezza delle chiese sarebbe venuta meno nel momento in cui, private dell’anima – ovvero la messa – le si fosse “musealizzate” e guardate esclusivamente da un punto di vista culturale, Proust faceva una distinzione importante e, se vogliamo, attualissima: quella tra cultura cristiana e fede cristiana ossia, usando le parole di Alberto Beretta Anguissola, uno dei massimi studiosi proustiani, tra ciò che è «adozione di un insieme di interessi, abitudini, opinioni e pensieri che fanno parte del “bagaglio antropologico” della tradizione cristiana» e quella che invece è la «certezza di poter risorgere con Cristo». Due realtà ben distinte e non intercambiabili perché, parafrasando un’espressione di papa Francesco, il cristianesimo non è una «proposta culturale» ma la sequela di Gesù.
Colpisce e sorprende allora l’intuizione di Proust, il quale nell’articolo sembra rimarcare anche terminologicamente la distanza tra i due ambiti: riferendosi a quello culturale, per ben due volte il romanziere utilizza l’aggettivo «gelido» mentre, nel caso di quello della fede, fa continuamente ricorso al sostantivo «vita». L’unico motivo, spiegava Proust, per cui le cattedrali gotiche erano state erette dagli artisti del XIII secolo, con le offerte di migliaia di anonimi fedeli, era la fede in Gesù; e la bellezza vivida che continuava a tremar loro d’attorno, ancora dopo tanti secoli, stava tutta nelle splendide celebrazioni eucaristiche che in esse si svolgevano: «Si può dire che grazie alla sopravvivenza dei medesimi riti nella Chiesa cattolica e, d’altra parte, della fede cattolica nel cuore dei Francesi, le cattedrali non sono soltanto i più bei monumenti della nostra arte, ma sono gli unici che vivano ancora integralmente la propria vita».

La cattedrale di Chartres
Mettete un cristianesimo estinto da secoli – ragionava per assurdo lo scrittore – del quale nessuno più ricorda le tradizioni ma di cui, tuttavia, resta traccia proprio nelle grandi cattedrali, divenute nel tempo monumenti «inintellegibili di una fede dimenticata»; aggiungete orde di scienziati intenti a ricostruire le cerimonie che in quei luoghi un tempo si svolgevano e artisti che si cimentano a rimetterle fedelmente in scena; amalgamate il tutto con la solerzia di uno Stato che, in tal caso, non si lascerebbe sfuggire l’occasione di sovvenzionare «la resurrezione delle cerimonie cattoliche, tanto grande è il loro interesse storico, sociale, plastico e musicale»; e in ultimo, ciliegina sulla torta, le immancabili «carovane di snob» a caccia di eventi mondano-culturali, ansiose di «assaporare l’opera d’arte nella cornice stessa che è stata costruita per accoglierla»: bene, vedrete – assicurava lo scrittore dalle colonne del Figaro – che «nonostante tutto» la ricetta non funzionerà. Ne verrebbero certamente fuori delle «retrospettive magari esatte, però gelide» e non si potrà fare a meno di pensare a come «queste feste dovevano essere più belle ai tempi in cui erano i sacerdoti che celebravano le messe, […] perché avevano, nella virtù di questi riti, la stessa fede degli artisti che scolpirono» le cattedrali in questione; e a come «doveva parlar con voce più alta, più intonata, l’opera intera quando tutto un popolo rispondeva alla voce del prete, si metteva in ginocchio al tintinnio della campanella», animato anch’esso dalla stessa devozione del sacerdote e dello scultore.
Questo perché, sosteneva Proust, lo splendore della «liturgia cattolica» forma «un tutto unico con l’architettura e la scultura delle nostre cattedrali»: nella prima, ogni elemento – dal composto fervore del popolo alla musica gregoriana, «sino al più piccolo gesto del prete, sino alla stola ch’egli indossa» – si accorda con «il sentimento profondo» che anima le seconde. Entrambe, liturgia e cattedrale, partecipano della stessa fede, della stessa vita, entrambe riverberano una bellezza che l’autore della Recherche riteneva inarrivabile: «Mai uno spettacolo paragonabile a questo, uno specchio gigantesco della scienza, dell’anima e della storia fu offerto agli sguardi e all’intelligenza dell’uomo […]. Si può dire che una rappresentazione di Wagner a Bayreuth […] è poca cosa accanto alla celebrazione della messa grande nella cattedrale di Chartres». Ed è significativo che il romanziere parli di «sguardi», oltre che d’«intelligenza», a lasciar intendere che, non solo quanti erano in grado di comprendere i rimandi e i segni propri della liturgia, ma davvero tutti, anche i semplici fedeli, potevano godere appieno di quell’evidente splendore: «Un ignorante, un semplice sognatore, entra in una cattedrale, si abbandona alle sue emozioni e prova un’impressione certamente più confusa, ma forse non meno forte».
L’importanza vitale della liturgia: ecco dunque il secondo punto nevralgico dell’articolo proustiano, anch’esso attualissimo. Piace a questo proposito ricordare un altro accenno di papa Francesco, dello scorso luglio, questa volta sull’attenzione delle Chiese ortodosse per la tradizione liturgica. Esse, spiegava il Pontefice al rientro dalla visita apostolica in Brasile, «hanno conservato la liturgia che è tanto bella. Noi abbiamo perso un po’ il senso dell’adorazione. Loro adorano Dio e lo cantano, non contano il tempo […] conservano questa bellezza di Dio al centro». Intuizione ripresa recentemente nell’omelia di una messa celebrata presso la Casa Santa Marta.
Parole che avrebbero certamente incontrato l’approvazione dello scrittore francese, il quale, peraltro, avrebbe apprezzato moltissimo l’accenno sul tempo. Proprio lui che nella Recherche, descrivendo la chiesa di Combray, spiegava come questa avesse «varcato e sconfitto, di campata in campata, di cappella in cappella, non solo qualche metro, ma epoche successive, dalle quali usciva in trionfo». Ecco, nella visione di Proust, la liturgia, come la «cattedrale vivente» con cui essa forma «un tutto unico», è senza tempo, o meglio lo attraversa senza esserne vittima.
Sembrano andare in questo senso anche i due ampi stralci riportati nell’articolo proustiano, tratti da L’art religieux du XIII siècle di Émile Mâle e dal Rational des divins offices di Guillaume Durand, nei quali viene minuziosamente descritto il simbolismo di ogni oggetto, paramento, gesto e canto facenti parte delle celebrazioni; come se in tal modo Proust avesse voluto sottolineare che niente nella santa messa, in cattedrale o in qualsiasi altra chiesa, fosse inutile e datato orpello: si trattasse della «grande celebrazione pasquale» o della semplice «cerimonia quotidiana», tutto quanto previsto dalla tradizione liturgica era non una stratificazione di vecchi e vuoti formalismi accumulatisi in secoli di cristianesimo, bensì continuo, vivo, rimando a Cristo e alle sacre scritture che raccontano la storia del cammino di Dio con l’uomo. Nel Tempo, in ogni tempo.

La chiesa di Saint Jacques a Illiers in una cartolina d’epoca. Nella Recherche proustiana la chiesa prenderà il nome di Saint Hilaire.
Ed è davvero sorprendente che, a conclusione dell’articolo, il romanziere abbia mosso il suo accorato appello in favore delle amatissime cattedrali e di tutte «le belle chiese di Francia» tirando in ballo proprio uno dei riti di devozione più semplici e antichi della tradizione cristiana; sicuramente tra i più cari al Popolo di Dio: «Là, dalle balaustre incantevoli di un balcone romanico o dalla soglia misteriosa di un portale gotico socchiuso, che fonde all’oscurità illuminata della chiesa il sole dormiente all’ombra dei grandi alberi che la circondano, noi dobbiamo continuare a vedere la processione che esce dall’ombra multicolore spiovente dagli alberi di pietra della navata e imbocca nella campagna, di tra le colonne tarchiate, sormontate da capitelli di fiori e frutti, quei sentieri dei quali si può dire, come il profeta diceva del Signore: “Tutti i suoi sentieri sono pace”».
Chissà che in questo frangente a Proust non fosse tornata alla mente la chiesa del suo paese natale, Saint-Jacques di Illiers, che, seppur con diverso nome, aveva voluto immortalare in Du côté de chez Swann, il primo volume della Recherche di cui si è appena celebrato il centenario della pubblicazione (14 novembre). A quel caro ricordo d’infanzia lo scrittore aveva voluto dedicare alcune tra le pagine più belle e più importanti della sua «cattedrale» di carta e parole, le prime dopo la celebre epifania della madeleine, nella quale il Narratore, assaporando il dolcetto francese imbevuto di tè (la petite madeleine appunto), sente riaffiorare dalle profondità del proprio inconscio le figure, gli ambienti e le emozioni d’infanzia. Così, il primo dei ricordi risvegliati dalla «memoria involontaria» va proprio a quella chiesa che «riassumeva la città, la rappresentava, parlava di lei e per lei ai lontani orizzonti e poi, quando ci si avvicinava, teneva stretti intorno al suo alto manto scuro, in aperta campagna, contro vento, come una pastora le sue pecore, i dorsi grigi e lanosi delle case raccolte»; e, qualche pagina più in là, al suo campanile, i cui pendii di pietra «s’avvicinavano innalzandosi come mani giunte»; e che «inatteso […] s’elevava davanti ai miei occhi come il dito di Dio, nascosto col corpo dentro la folla degli umani senza che per questo io potessi confonderlo con loro».
Per un breve commento dell’articolo, vedi anche qui